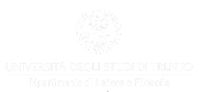Una diagnosi psichiatrica non è mai neutrale. Questo non è un rischio legato solamente al contesto di vita, che con discreta probabilità proverà ad ascrivere ogni successivo comportamento difforme rispetto alle aspettative come una riaccensione sintomatologica («… siamo alle solite, farnetica..!»): lo stesso rischio è intrinseco al nostro operare, che troppo spesso ingessa le spinte evolutive catalogandole come ricadute. Con ciò non sto negando l’esistenza della sofferenza psichica, che esiste eccome, come esiste la patologia. Solo che non mi piacciono le semplificazioni, quella grossolanità che sta dietro ogni atteggiamento categoriale che amputa la complessità e la dignità della sofferenza umana in nome di un bisogno classificatorio. Per cui non amo l’approccio clinico in senso stretto. Se invece lo consideriamo uno strumento provvisorio, debole ma anche efficace nel comunicare rapidamente, va benissimo purché, quando si dice a un collega «ho visto un paziente psicotico paranoideo», non si pensi che il paziente sia solo quella cosa lì. La sua vita e la sua complessità umana sono decisamente molto più di quanto espresso da quelle categorie. In questa semplificazione sta tutto l’orrore ed errore della psichiatria, da lì sono derivati tutti i guai.
Come si riesce a convivere con la responsabilità di clinico? In particolare penso alla difficoltà di definire una persona come “normale” o “anormale”, e alle conseguenze di queste diagnosi “non neutrali”…
Dal punto di vista filosofico mi verrebbe da rispondere citando Edmond Jabès, che ha scritto un libriccino dal titolo Il libro dell’ospitalità, nel quale afferma: «Al di qua della responsabilità sta l’ospitalità». Lo argomenta molte volte nel corso di questo bellissimo libro affermando che, piuttosto che di responsabilità, in cui si è chiamati a rispondere per qualcun altro, è meglio parlare di ospitalità, intesa come disponibilità a farsi sor-prendere da un’altra persona, a farsi avvicinare, all’interno di una reciprocità che resista alla tentazione di dare subito un nome a colui che arriva, allo straniero. Questo stile aperto, ospitale appunto, non può d’altro canto divenire l’alibi per dire: la vita è una cosa imprescindibile, alla fine ognuno è responsabile delle proprie scelte. Non è vero neanche questo – sarebbe, mi pare, una consegna di solitudine – perché ci sono situazioni che incontriamo ogni giorno, situazioni di grande disordine emotivo, in cui il nostro aiuto e contenimento può evitare che uno si butti dal ponte, può attenuare fasi di estremo malessere che potrebbero altrimenti risultare assai dolorose e prolungate. Allora, tornando alla responsabilità, è un problema molto pesante, e forse l’esperienza più drammatica è quando un paziente si ammazza e tu ne avevi la “responsabilità terapeutica”. In questi casi io credo che la situazione peggiore sia quando ti cogli disattento, distratto, molto più di quando ti riconosci incapace di decifrare i segni premonitori. Se il giorno prima hai visto un paziente che l’indomani si è suicidato, fai fatica a perdonarti la disattenzione, meno il fatto di non aver registrato elementi di rischio. Mi spiego: non credo esistano criteri clinici infallibili di previsione del rischio suicidario, mentre esistono avvertimenti che suonano attraverso i canali della sensibilità, che ovviamente suonano se la nostra sensibilità è per così dire ‘a disposizione’. Questa ‘attenzione a non essere disattenti’ è una delle fatiche del nostro lavoro. Noi lavoriamo con le emozioni degli altri e, a nostra volta, abbiamo il nostro fardello di emozioni: è questo il vero casino. Qualcuno pensa di poter risolvere il problema lasciando fuori i problemi personali, operando una sorta di scissione, ma in realtà occorre avere un doppio registro di attenzione, uno rivolto al paziente e uno a ciò che il paziente desta dentro di me (si potrebbe arrivare a dire: al paziente dentro di me…). Se poi consideriamo che tutti i mestieri sono un po’ autobiografici, beh, a volte è un po’ complicato. In aggiunta c’è anche un problema numerico, ovvero la pesantezza di avere più di 200 pazienti in carico, come succede ai colleghi che offrono una presa in carico longitudinale, nel tempo. Uno psichiatra del servizio pubblico ha in media 150-200 pazienti, talvolta di più. In una settimana lavorativa che è fatta di 40 ore, a cui togliere le riunioni, varie incombenze istituzionali, le statistiche, le carte, i certificati, eccetera, il tempo dedicato direttamente alle persone diventa meno della metà e ciò significa che, se va bene, nelle 20 ore disponibili alla settimana dovremmo avere in testa 150-200 pazienti.
Quali sono gli elementi di gratificazione che danno il senso del lavoro e giustificano tutta la fatica e la complessità di cui ci sta parlando?
O do una finta risposta generica o ne do una molto personale, così personale che dubito possa risultare davvero interessante… Credo di sapere perché a me, nonostante tutto e nonostante diversi lustri di professione alle spalle, piace ancora fare questo mestiere, ma è la mia risposta: non ho quindi nessuna pretesa che possa valere per altri. Io avverto tre radici che mi hanno avvicinato e che ancora mi legano a questo mestiere: una, la metto per prima, è una radice estetica, cioè la follia è un fenomeno che mi interessa, mi intriga, mi affascina. Ma il mio interesse non è volto primariamente all’interpretazione, non sono cioè particolarmente interessato alla sua traduzione in un linguaggio coerente; sono stupito, ammirato, talvolta travolto da questa sua natura oscura. Una seconda dimensione è quella politica, per cui penso che questo è un mestiere sporco che deve avere consapevolezza del suo essere sporco ma rappresenta anche l’utopia di una trasformazione degli assetti sociali e dei rapporti interpersonali. Diceva Felix Guattari che la riforma psichiatrica italiana è stata la più grande riforma non violenta del Novecento. Non so se lui fosse preso da un’enfasi eccessiva, però un po’ mi pare avesse ragione. Penso a tutto quello che è conseguito alla riforma psichiatrica, pur con tutte le sue luci e le sue ombre; penso a come è cambiata la vita dei pazienti. Ho cominciato a lavorare quando ancora c’erano i manicomi: le malattie erano le stesse di oggi ma le vite dei pazienti erano così diverse… Dimensione politica vuol dire quindi sviluppare un’intelligenza politica rispetto ai problemi e quindi non soltanto sensibilità intimistica personale; vuol dire cogliere il ruolo della follia in una società che si dice civile e tentare di dialettizzarlo. Mi piace dire in modo scherzoso che dobbiamo divenire ambasciatori terreni della follia, perché in fondo la follia rappresenta una trascendenza. Ecco, questa è una cosa che mi interessa e mi piace ancora molto. Vi è un’ultima radice, la terza, non meno importante. Mentre colgo un che di arrogante ed impudico nell’esercizio supponente dell’interpretazione a tutti i costi, percepisco ancora l’incontro con i pazienti come un privilegio che mi permette di incontrare altri esseri umani, altri sguardi e declinazioni del vivere. Questo mi impone di rileggermi, di mettermi in discussione, mi permette di pensare a cosa farò da grande: questo mi piace e lo ritengo un privilegio. Se alla mia età penso a cosa farò da grande lo devo soprattutto al fatto che ogni giorno incontro delle persone che sovvertono in me tutto quello che tenderebbe a cristallizzarsi in forme di esistenza precostituite. Questa dimensione relazionale si collega in me certamente a una dimensione affettiva, di autentico conforto umano derivante dal poter condividere con altri sensibilità, esperienze e fatica del vivere.
(a cura di Tiziana Faitini e Lucia Galvagni)