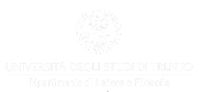Una cosa che mi preoccupa molto nel mio lavoro è vedere che è saltato il meccanismo di base per cui si lavora per la certezza di migliorare la propria qualità di vita a breve. Questo meccanismo apparteneva alla generazione precedente, meno alla mia generazione, quella dei quarantenni, e meno ancora alla generazione dei nostri figli. La prospettiva è di un evidente peggioramento: a maggior lavoro non corrisponde maggior benessere. C’è da dire che, in generale, conduciamo una vita al di sopra delle nostre possibilità economiche effettive, specie nella realtà trentina, e questo svaluta non poco la disponibilità all’impegno. Ho insegnato per molti anni in Università e quello che ho potuto constatare è che i nuovi ingegneri hanno competenze minori e frammentarie, sia nei contenuti che nel metodo: gli studenti oggi non fanno neanche la fatica di raccogliere il materiale di studio, come possiamo insegnar loro a risolvere i problemi? Inoltre, ho visto poca preparazione all’impegno e alla responsabilità: scarsa capacità di autovalutazione e, insieme, difficoltà di valutazione da parte dei docenti e delle famiglie. Il risultato sono alte aspettative che si scontrano con un calo di professionalità e di remunerazione. L’università, poi, è totalmente scollata dal mondo reale: si è assistito alla proliferazione di corsi e all’accentuazione della ricerca quando ingegneria è in realtà una facoltà che deve essere anzitutto professionalizzante.
Quali sono i problemi etici che incontri nel tuo lavoro?
Mi occupo di ingegneria gestionale, quindi di gestione del magazzino, dello stoccaggio e delle forniture dei terzisti, anche nell’ottica della ristrutturazione dell’organizzazione aziendale. Il problema principale, per me, è anzitutto quello dell’accettazione del sistema economico generale e di un modello di sviluppo poco sostenibile. Lo vedo molto bene nel mio lavoro perché alcune scelte migliori per l’organizzazione e la produttività aziendale sono, su scala globale, troppo impattanti. Ad esempio, è sempre più frequente ricorrere a un maggior numero di forniture annue allo scopo di ridurre l’investimento richiesto dal magazzino e le giacenze, ma questo implica un maggior numero di viaggi e un impatto ecologico più consistente, oltre a un’organizzazione del lavoro molto flessibile da parte dei fornitori. Dato che tutto ciò comporta una maggior disponibilità di liquidità per l’azienda, si dovrebbe dare una maggior disponibilità a ricompensare la flessibilità dei dipendenti e dei fornitori, redistribuendo parte degli utili. Tuttavia non è assolutamente automatico che ciò accada e spesso si finisce col riorganizzare in modo flessibile gruppi di lavoro e fornitori senza adeguata ricompensa.
Anche l’eccesso di dedizione al lavoro, per me, è un problema etico. Io lavoro molto e lo faccio per garantire un futuro migliore ai miei figli, ma finisco per sacrificare gli affetti familiari, paradossalmente per amore della famiglia. Dov’è il limite?
L’ordine professionale gioca un ruolo all’interno di queste dinamiche?
L’ordine professionale, così com’è, ha un ruolo inesistente. Anzi, ha un ruolo negativo: non è che a tutela di interessi acquisiti e a svantaggio dell’inserimento dei migliori. È significativo solo per gli ingegneri civili e ha come unica preoccupazione il controllo delle parcelle minime, per vietare la partecipazione a appalti con base troppo bassa, mentre dovrebbe effettuare reale controllo sulla qualità, prima che debba intervenire il potere giudiziario. Invece l’esame di stato è una farsa che chiunque può superare: chiunque può esercitare e diviene impossibile il discernimento delle effettive competenze e capacità in un gioco collettivo al ribasso. Questo rimanda al discorso sull’incapacità di selezionare e valutare, a partire dalla scuola.
(a cura di Tiziana Faitini)