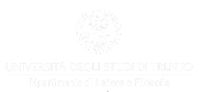In quanto insegnante di una scuola pubblica ho un mandato istituzionale preciso, che si struttura anzitutto attorno ai valori costituzionali.
In un contesto come il nostro io mi riconosco in tali valori, che strutturano una convivenza democraticamente ispirata, e dunque ho in essi un riferimento forte, che posso rivendicare e che mi tutela. Diverso è naturalmente il caso di regimi politici diversi, come diverso è il caso dell’insegnamento nell’ambito di istituzioni private in cui entrano in gioco riferimenti valoriali differenti: qui, al mandato istituzionale, presente nel caso di scuole equiparate, si aggiungono valori che possono essere ricondotti ad una confessione religiosa o, più concretamente, a esigenze che derivano dal profitto economico (che, ad esempio, vincolano molto spesso le decisioni di bocciatura-promozione in relazione alla necessità di conservare le iscrizioni, ossia il lavoro per sé, per la scuola e per i colleghi anche per gli anni a venire).
A fianco del mandato istituzionale che, nella scuola pubblica, è definito dalla Costituzione, gioca il riferimento valoriale dell’altro con cui entro in rapporto, ossia l’alunno e la sua famiglia, con il sistema valoriale di cui essi sono portatori (con un ruolo più o meno preponderante della famiglia in base all’età: nel mio caso, quello di ragazzini delle scuole medie, il confronto è anzitutto con la famiglia di provenienza).
Si potrebbe quindi dire che il lavoro dell’insegnante si muove alla ricerca di un equilibrio e di una distanza rispetto all’asse del mandato istituzionale e, perpendicolare ad esso, all’asse della singolarità della persona, delle sue esigenze e dei suoi valori. Abbiamo a scuola il caso di un ragazzino islamico che non accetta le donne come insegnanti, rifiutandosi di eseguire ciò che gli viene richiesto poiché il suo contesto di provenienza gli ha insegnato a non riconoscere autorità o potere alla figura femminile. In questo caso, se il nostro contesto istituzionale prevede la parità tra i sessi e dunque autorizzerebbe a ignorare sia le pretese che la plausibilità delle giustificazioni del ragazzino, ci si deve chiedere quanto ciò sia efficace se lo scopo è perseguire l’educazione dell’alunno e il bene comune: ci si trova forse a doversi avvicinare e entrare in dialogo con l’asse della persona, stabilendo una sorta di alleanza formativa con la famiglia.
La cura della relazione in questo lavoro mi sembra un aspetto imprescindibile.
È sempre importante muoversi sul versante relazionale, anche collegialmente. Questo è molto importante rispetto a quel momento problematico che sono i consigli di fine anno, dove, di fronte alle decisioni di promozione e bocciatura, si sente l’istituzione scuola scricchiolare nella sua interezza. Si tratta di decisioni che possono significativamente influire sulla vita del ragazzo e della sua famiglia e che, dall’altro lato, devono tener conto del raggiungimento di determinati obiettivi formativi. Insegno da dieci anni ed ogni anno, per ovviare a questi momenti di crisi, qualcuno propone di approvare una norma interna (che comunque è discussa anche a livello centrale, ora approvata per quel che concerne la non ammissione all’esame con 4 insufficienze) che preveda la bocciatura con un certo numero di insufficienze. A quel punto sarebbe la norma a non essere etica: si tratterebbe in effetti di uno strumento di risoluzione che ha un’eticità a mio parere dubbia e che, comunque, finisce col lasciare la decisione in modo non trasparente e non collegiale al singolo insegnante, che può semplicemente decidere di alzare o abbassare alcuni voti. A me sembra che l’unica uscita sia il dialogo fra le parti, ossia fra insegnanti e famiglia, per condividere la responsabilità della scelta. Ciò richiede la costruzione di una relazione significativa pregressa, che consenta almeno su qualche punto un’alleanza con la famiglia e con il suo schema di valori di riferimento. Se ciò non accade – perché non c’è disponibilità, per errore mio o perché ad esempio nelle classi prime ne manca il tempo – mi sembra che manchino gli elementi per una scelta e dunque in dubio pro reo: gioco a favore del ragazzo, per cui, posto che nessuno conosce gli esiti, mi sembra più prudente attendere e magari pensare di rimandare la decisione all’anno successivo se possibile. La questione si porrebbe diversamente per le scuole di ordine superiore, poiché diversa è l’autonomia di scelta delle persone in quella fascia di età e diverso è il profilo in uscita previsto a livello ministeriale.
Nella tua esperienza di referente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con quali questioni eticamente rilevanti ti confronti?
La legislazione provinciale sui BES, pur essendo ispirata dai migliori principi di integrazione e di fuoriuscita dall’ambito sanitario, sta di fatto tradendo questi stessi principi. In fin dei conti non è passata la finalità ultima, specie tra le famiglie, che molto spesso ritengono di tutelare al meglio i propri figli appellandosi alla certificazione, contestando iniziative dell’insegnante e chiedendo l’applicazione letterale di tutte le agevolazioni previste, senza realizzare che possono non essere sempre necessarie e, soprattutto, che possono tradursi in stigmatizzazione. Il computer è uno strumento importante, ma non è la risposta a tutte le esigenze di un ragazzino dislessico che forse in molti momenti ha bisogno di esser messo di fronte alla fatica dello scrivere – il che significa parimenti esser messo di fronte all’accoglienza pura e aperta del suo modo di scrivere: in fondo, del suo essere, al di là di ogni confronto con uno standard medio, prima di ogni misura compensativa che, per il semplice fatto di essere messa in atto, rimarca in continuazione un’insufficienza e, con essa, la propria necessità.
Come si può contribuire a fare di un insegnante un buon insegnante?
Di fronte alla peculiarità di ciascun caso, una risposta univoca e normativamente stabilita a priori è difficilmente pensabile. Uno strumento importante è quindi la raccolta delle buone prassi, che concretamente, al di là della via narrativa in senso stretto, può tradursi ad esempio nella stesura di un protocollo interno di “consigli della nonna” che, senza valore normativo e vincolante, consentono di coprire l’inesperienza di un insegnante o quella che, per qualsivoglia motivo, può essere la sua mancanza di consapevolezza. L’insegnamento è un lavoro pratico e nella formazione un punto importante è costituito dalla trasmissione delle buone prassi: al di là delle competenze culturali e tecniche (su cui il percorso universitario fornisce una certa preparazione, negli ultimi anni in modo forse più soddisfacente anche sul versante tecnico della didattica), è un lavoro che intreccia la dimensione di cura e la dimensione artigianale del fare e, quindi, dell’apprendere per imitazione e per condivisione di esperienza. In questa direzione la via narrativa mi sembra una strada importante. C’è la necessità di aprire spazi di confronto e dialogo, meglio se guidati da una figura esterna che sappia finalizzare e quindi permettere la rielaborazione di ciascuno, dando vita a un’autoformazione dell’insegnante. Un’osservazione esterna che si traduca in restituzione narrativa consente di capire criticità e positività, di bilanciare l’alto livello di frustrazione e di dare un ritorno anche in termini di soddisfazione.
È molta la frustrazione?
È evidente che, se guardo ai miei colleghi, non tutti hanno lo stesso livello di motivazione che li porta ad accettare investimenti di tempo contrattualmente non richiesti e non tutti sono soddisfatti. E se ci chiediamo il perché, il primo motivo è facile a vedersi: oggi e in Italia in particolare, l’insegnante è svalutato. È venuto meno il prestigio sociale che lo distingueva, che giustificava una certa autostima fondando un’identità forte e che, in misura non indifferente, semplificava i rapporti e l’esercizio del proprio mestiere; manca ogni riconoscimento economico ed ogni distinzione di carriera (che, del resto, è talmente difficile da pianificare giustificatamente che forse il male minore è la sua assenza, in attesa di idee migliori).
Il secondo motivo è più sottile: l’insegnante semina, ma non raccoglie. Intrinsecamente, specie con i più giovani, il suo lavoro si gioca su una scala temporale troppo estesa e i risultati sono usualmente impossibili a vedersi. Difficile identificare le ragioni di un fallimento o di un successo, inutile tentare di attribuire la responsabilità degli errori di fronte a una controparte agente se non autonoma, arduo persino capire, più radicalmente, se di fallimento o di successo si tratta: solo il tempo potrà dirlo, e non lo dirà a te. Paradosso intrinseco, di cui, ancora, solo un ritorno narrativo può tentare una composizione.
Il momento storico e questa aporia interna spiegano forse perché l’identificazione personale con il proprio lavoro sia fallimentare e rischiosa. Gli inglesi ci insegnano che il burn out dell’insegnante cresce con l’assenza di distacco e che la prima terapia è la coltivazione di altri interessi. Come a dire che, nella quasi assenza di riconoscimento sociale e nell’incertezza dei risultati, di altre risorse deve arricchirsi la costruzione dell’identità personale e del progetto esistenziale.
(a cura di Tiziana Faitini)