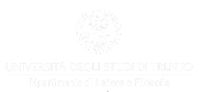Quanta distanza c’è, secondo lei, tra la figura idealizzata dell’avvocato, che si fa tutela della parte più debole o della giustizia, e la pratica?
A mio giudizio l’avvocatura soffre di questo tipo di stereotipo di cui lei mi ha parlato e la categoria non è stata capace di valorizzare quanto ampio sia il contributo all’andamento della giustizia. Le faccio pochi esempi. Se gli avvocati smettessero di svolgere le loro funzioni per il funzionamento della magistratura, probabilmente i tribunali si paralizzerebbero. Questo perché i giudici onorari, per esempio, sono quasi il doppio della magistratura togata e consentono il funzionamento di tantissimi uffici sul territorio; i vice procuratori onorari che svolgono il lavoro di pubblica accusa nelle udienze penali per reati più semplici sono quasi tutti avvocati; i giudici onorari nei tribunali sono quasi tutti avvocati; gli avvocati compongono, ad esempio, tutte le commissioni di manutenzione dei palazzi di giustizia e fanno parte di tantissime commissioni dando il loro contributo per il funzionamento del meccanismo complessivo. A Trento, pochi lo sanno, gli avvocati garantiscono la difesa dei non abbienti: non soltanto per istruire le pratiche di patrocinio a carico dello Stato – e le assicuro che sono tantissime, perché a Trento, che è una realtà economica privilegiata, quest’anno abbiamo istruito 300 pratiche ed è solo settembre –, ma anche tramite uno sportello in cui gli avvocati forniscono un aiuto gratuito al cittadino per presentare queste domande e per spiegare i diritti. Abbiamo avvocati che fanno parte degli avvocati di strada, dei sindacati… Insomma, esiste un servizio diffuso che è poco conosciuto.
Dopodiché l’avvocato ha come strumento la conoscenza della legge e quindi sostanzialmente dà al proprio cliente questa capacità al fine di perseguire quello che è l’interesse del suo cliente. Utilizzando in maniera lecita lo strumento normativo, credo che l’avvocato attui l’interesse di giustizia e di rispetto della regola, che passa anche attraverso una formalità di utilizzo corretto della regola. Se poi lei mi dice che ci sono anche gli avvocati falsi che fanno concludere dei contratti poco trasparenti e che rientrano in quella che lei definiva una sorta di zona grigia, direi che Trento conosce poco questo tipo di casistica: forse più legata a città dove ci sono grossi movimenti finanziari, a Trento non mi risulta ci sia questa zona grigia. Se poi si dice all’avvocato: “Dimmi qual è la strada corretta” e poi scegli una scorciatoia, io questo non lo interpreto come una zona grigia, ma come un utilizzo della norma in maniera lecita: siamo sempre nell’ambito del lecito. Probabilmente questi casi si verificano in ambito finanziario.
Succede che un avvocato rifiuti una causa perché indifendibile rispetto ai propri principi etici personali?
Può darsi che succeda. Io devo dire che l’ho sempre vista da un angolo diverso. Le parlo a titolo personale. A me è successo di pormi il problema circa la mia capacità di difendere adeguatamente un soggetto che aveva commesso un reato che io reputavo particolarmente disdicevole. Me lo sono posto non perché pensassi che questo soggetto non meritasse di essere difeso – questo sì verrebbe meno alla mia professionalità: sono fermamente convinta che ognuno di noi abbia diritto di essere difeso e di vedere garantiti i propri diritti e il rispetto delle regole processuali. Invece, mi era sorto solo il dubbio di non utilizzare, magari inconsapevolmente, tutta la diligenza che io ho l’obbligo di impiegare nello svolgere il mio lavoro perché il soggetto che avevo davanti mi creava una sorta di repulsione. Mi è successo in alcuni casi di violenza sessuale grave nei confronti di minori: sorge in me un istinto di rifiuto alla difesa. In questo caso l’ho risolto affiancando alla difesa un collega, come una sorta di cartina di tornasole della mia attività nel senso di avere il conforto di fare tutto il possibile nonostante il soggetto o le azioni di quel soggetto mi risultassero da un punto di vista etico particolarmente sgradevoli. Però me la sono posta dalla parte opposta: non del non doverlo difendere, ma del doverlo difendere in maniera adeguata. Non sempre si riesce ad essere asettici rispetto alle situazioni con cui ci si confronta. In questi casi mi è capitato più volte di essere particolarmente pesante nei confronti delle madri. Abbiamo sempre delle madri che ti dicono: “Ah io non mi sono accorta di niente”. La reazione per me è quasi violenta, perché non è possibile! L’ultima volta le ho detto: “Non ci provi neanche a raccontarmelo” tant’è che mi ha telefonato l’assistente sociale dicendo che ho aggredito la signora: è vero, non credo che sia possibile. Questo è il coinvolgimento che si ha dopo magari tanti anni che aiutano a rendersi conto di determinate dinamiche e a capire chi si ha davanti.
Quanto è importante per lei il suo lavoro? E secondo lei il rapporto tra il professionista e il proprio lavoro sta cambiando?
Non è facile rispondere a questo tipo di domande. Partiamo dal piano personale. Io ho sempre desiderato diventare avvocato, non ho fatto giurisprudenza perché non sapevo cosa fare. L’ho iniziata anche con una spinta ideale, nel senso che sono sempre stata convinta che la mia professionalità potesse essere d’aiuto agli altri. Ho investito moltissimo nella mia professione ed è difficile pensare che sia qualcosa di diverso rispetto alla mia personalità: lavoro dodici ore al giorno come avvocato quindi è difficile riuscire a non creare un’identità tra quello che sono e quello che faccio. Se dovessi fare una scala delle priorità è chiaro che la priorità è la famiglia, però non potrei pensare di vivere senza un lavoro. Fare bene l’avvocato è essere diligenti, poi c’è quel 5% di genio che magari ti fa finire sul giornale. Adesso è più difficile, forse perché è più difficile per un giovane emergere oggi. Io dico sempre, però, che c’è spazio per chi è fortemente motivato. Non so dare una risposta al fatto se sia o meno cambiato nel tempo questo rapporto.
Sicuramente la figura dell’avvocato deve cambiare nel senso che non possiamo più permetterci di continuare a far pensare alla gente che siamo degli azzeccagarbugli. Bisogna recuperare quella che è la funzione sociale dell’avvocatura: di solito se ne accorge soltanto il cliente che viene, quasi sempre per necessità, e quindi scopre qual è la vera funzione dell’avvocato. Bisogna far capire dal punto di vista dei diritti qual è la funzione dell’avvocatura e questo implica anche inventarsi una professione diversa, e l’ordine professionale può avere un ruolo in questo. Io sono convintissima che il futuro non sia nel processo, ma fuori dal processo. Sotto questo profilo ci deve essere un cambiamento nella funzione dell’avvocato: deve essere visto come una medicina preventiva più che come una soluzione inesorabile quando c’è un problema che non trova altro tipo di rimedio. Una funzione preventiva, una funzione culturale, una funzione di mediazione prima di arrivare davanti al giudice. Certo i numeri degli avvocati non aiutano una qualità di questo tipo: il grande numero porta a coltivare la lite per avere la possibilità di lavorare. Questo è quello che secondo me la politica non ha capito quando parla di liberalizzare una professione intellettuale, che non è vendere una merce, ma dare una prestazione intellettuale che non si può svendere. Evidentemente si deve lavorare sulla qualità e non sul numero di professionisti per abbassare il prezzo della prestazione a scapito dei diritti. Qui, a Trento, abbiamo ancora una realtà di tipo artigianale rispetto alle altre regioni italiane. In altri posti stiamo importando la caratteristica di altri stati, come gli Stati Uniti, dove esiste un’idea più imprenditoriale della professione. Noi stiamo cercando di resistere a questo tipo di modello, ma probabilmente non resisteremo a lungo: la nostra è una nicchia di privilegio per la nostra realtà territoriale e il nostro tessuto sociale privilegiato che ci consente di svolgere la professione in una determinata maniera.
(a cura di Tiziana Faitini)